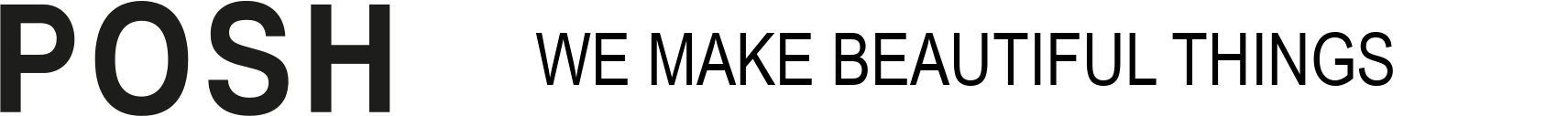Da tre decenni riscrive le regole del cinema indipendente. Sovversivi ed eleganti i suoi film indagano la politica, la psicologia e la cultura pop americana. Con The Velvet Underground, al cinema e in streaming su Apple TV+, Todd Haynes spinge ora il documentario musicale verso i suoi limiti artistici più estremi e innovativi
Con soli otto lungometraggi, sapientemente centellinati in trent’anni di carriera, Todd Haynes è diventato un maestro nel trasmettere realtà emotive in tutto il loro splendore. I suoi film, interpretati da star del cinema glamour, si dispiegano con ritmi seducenti e piacevoli, sollevando domande provocatorie sulla società contemporanea. Haynes, che ha studiato semiotica alla Brown University di Providence nel Rhode Island, si è velocemente affermato come uno dei più intraprendenti autori statunitensi. Guadagnò notorietà già nel 1987 quando, dirigendo una decostruzione a base di bambole Barbie della tormentata vita di Karen Carpenter, incappò in una sentenza che, per via dei diritti musicali dei Carpenters, ne impedisce tuttora qualsiasi proiezione pubblica. Con Poison, suo primo lungometraggio e pietra miliare del New Queer Cinema, finì addirittura sotto le infuocate critiche dei fondamentalisti cristiani dell’American Family Association. Ardito iconoclasta, Haynes è da sempre un abile rinnovatore di autori dell’età d’oro di Hollywood come Max Ophüls, John Malcom Stahl o Douglas Sirk. Dalle pressioni dell’esistenza moderna in Safe, minaccioso dramma sulla malattia ritornato in auge nell’epoca del Covid, allo struggimento dell’amore oltre i limiti consentiti dalla società in Carol, passando per la ricerca di giustizia sociale e ambientale nel legal-thriller Dark Waters – Cattive acque, tutti i lavori di Haynes si distinguono per essere riccamente strutturati, emotivamente astuti e profondamente radicati in specifici e tumultuosi momenti della storia americana. Al 17° Zurich Film Festival, dove lo abbiamo incontrato, il sessantenne regista ha presentato il suo ultimo lavoro, The Velvet Underground, un viaggio nel tempo e nello spazio alla ricerca dell’essenza più rivoluzionaria e anticonformista della mitica band composta da Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison e Maureen “Moe” Tucker, e che ebbero in Andy Warhol il loro mentore. Il risultato, visibile dal 15 ottobre sui grandi schermi e sulla piattaforma Apple TV+, è un documentario in grado sia di raccontare in maniera analitica la storia di un gruppo musicale che cambiò per sempre il rock and roll, che di trasportarne l’anima estetica e acustica con un attento lavoro su immagini e suoni.
La musica ricorre frequentemente nei tuoi film. Da Superstar: The Karen Carpenter Story (1987), biografia sperimentale della celebre cantante, a Io non sono qui (2007), rilettura artistica di Bob Dylan, passando per Velvet Goldmine (1998), ispirato al glam rock degli anni ‘70. Come mai ora un documentario sui Velvet Underground?
Premetto che fare un documentario sui Velvet Underground non è stata una mia idea. La proposta mi è arrivata dopo che Laurie Anderson diede alla New York Public Library gli archivi di Lou Reed, suo defunto marito. Fu allora che Merrill Reed Weiner, sorella di Lou, insieme all’etichetta discografica UMG, contattò Laurie chiedendole se fosse il momento giusto per fare un documentario sulla band e quali sarebbero stati i registi che avrebbe consigliato. È stato fatto il mio nome e ho subito accettato. Poiché ero troppo piccolo non ho mai visto dal vivo i Velvet Underground, ma li ascoltavo quando frequentavo il college e la loro musica ebbe su di me un impatto enorme. Mi sono reso conto molto rapidamente che era alla base di tutti i tipi di musica a cui mi ero avvicinato, che fosse punk rock o glam rock, o anni dopo l’indie rock. I Velvet Underground è stata una band che pochissime persone conoscevano all’epoca, ma che riuscì a influenzare non solo intere generazioni di musicisti ma anche di molti artisti e creativi. Non per niente si dice che abbiano creato l’arte del rock and roll. L’esperienza completa delle performance dei Velvet Underground non era semplicemente relegata alla sonorità o alla narrazione, ma era anche intrisa di una forte componente visiva che attingeva dalle tradizioni avanguardiste, dalle loro associazioni con il mondo dell’arte di New York e della Factory di Andy Warhol, e dall’era di straordinaria innovazione artistica che caratterizzò gli anni ’60. Le loro esibizioni potevano incorporare suoni inquietanti, temi dark, elementi di dolore e differenti identità sessuali.
Quanto sono stati disposti a contribuire John Cale e Maureen Tucker, membri superstiti della band?
John Cale si è dimostrato molto disponibile e generoso. Poiché Lou Reed è deceduto, sulle sue spalle grava l’intera eredità dei Velvet Underground. Le numerose collaborazioni creative di Lou sono state molto conflittuali, ma nessuna è paragonabile a quella avuta con John Cale. Le testimonianze e le descrizioni di John su Lou, ancora molto vivide, contengono un tale serbatoio di sentimenti d’amore, frustrazione e dolore, dimostrando quanto i loro anni formativi siano stati condivisi. Era importante trovare anche Maureen, il che ha richiesto un po’ di tempo: vive nelle zone rurali della Georgia settentrionale e si occupa principalmente dei suoi nipoti. Doug Yule, il musicista che ha sostituito John Cale, non era invece interessato a partecipare al progetto e ciò mi ha molto deluso. Al contrario della maggior parte dei membri superstiti della Factory di Andy Warhol che, anche dopo cinquant’anni, rimangono una famiglia disfunzionale: c’è voluto solo un po’ di seduzione e persuasione affinché si sentissero a loro agio davanti la telecamera.
Anche Lou Reed è molto presente nel film anche se non hai avuto modo di parlare direttamente con lui…
Includerlo è stata una delle sfide narrative del film, che non sarebbe stato lo stesso se Lou fosse ancora vivo permettendomi d’intervistarlo direttamente come avrei invece desiderato. Siccome non è più con noi, abbiamo raccolto tantissime registrazioni e interviste disponibili, utilizzando le sue dichiarazioni sulla band rilasciate nel corso degli anni. Le sue immagini nell’intervista accanto ad Andy Warhol o sul palco assieme a John Cale assumono un impatto ancora più emotivo e potente, sapendo che non c’è più.
Il montaggio sincopato di The Velvet Underground è arricchito dal sapiente uso dello split screen; come sei arrivato a questa scelta estetica?
La tecnica del dittico, ovvero lo schermo diviso in due fotogrammi e che caratterizza gran parte del film, è un omaggio diretto a Chelsea Girls, il film con cui Andy Warhol iniziò a usare nei suo lavori la doppia proiezione. Warhol fu anche l’artefice delle proiezioni multiple durante le performance dal vivo dei Velvet Underground, che includevano effetti stroboscopici, luci colorate e ballerini. Un fotogramma può muoversi, crescere o ridursi: ci vuole molta pianificazione, e la stampante ottica, dispositivo composto da uno o più proiettori meccanici collegati a una macchina da presa, è una componente chiave per far sì che questo effetto accada. Questa particolare formattazione dello schermo fu frequentemente usata negli anni ’60, e la si può osservare nei film sperimentali dei designer Charles & Ray Eames, in quelli industriali dal forte immaginario estetico, e perfino in pellicole come The Boston Strangler – Lo strangolatore di Boston di Richard Fleischer, The Thomas Crown Affair – Il caso Thomas Crown di Norman Jewison o in Woodstock – Tre giorni di pace, amore e musica, il documentario che racconta l’omonimo festival tenutosi a Bethel nell’agosto del 1969. Ho ritenuto avesse quindi un senso logico utilizzare questa tecnica di composizione a più fotogrammi anche per The Velvet Underground.
Parlando di schermi, hai realizzato The Velvet Underground per il cinema o la televisione?
Come per tutti i miei film anche quest’ultimo è stato concepito per il cinema. Persino mentre giravo la serie televisiva Mildred Pierce, trasmessa dal canale HBO, la immaginavo per il grande schermo. Quando due anni fa iniziammo a cercare distributori per The Velvet Underground l’uscita sul grande schermo era la nostra priorità. La Apple si disse subito favorevole e dal 15 ottobre il film potrà essere visto in selezionate sale nordamericane ed europee oltre che in streaming sulla piattaforma Apple TV+. Se avete intenzione di guardarlo dal divano di casa vostra, fatelo sul più grande schermo possibile e a tutto volume. I film sono bidimensionali, anche se possono ingannarci con l’idea del 3D. Il suono è invece tridimensionale perché ci avvolge. E Leslie Schatz, il mio sound designer, è stato molto attento affinché il suono potesse essere sentito in qualsiasi punto del salotto. Anche se il miglior impianto cinematografico casalingo non sarà mai all’altezza di un sistema cinematografico professionale.
La tua carriera è prevalentemente associata al cinema indipendente d’autore. Non ti ha preoccupato collaborare con colossi come Amazon o Apple?
Ogni film e ogni rapporto di lavoro è unico. Ad Amazon, che ha distribuito nel 2017 Wonderstruck – La stanza delle meraviglie, Roy Price, a quel tempo presidente della divisione sviluppo dei media, aveva ottenuto il permesso di lavorare con registi indipendenti e di investire considerevoli risorse. Per quel film il tempismo è stato perfetto, tenuto conto che, per una serie di motivi, quella finestra d’opportunità non è durata molto a lungo. Sono entità aziendali in continuo cambiamento, che costantemente si ridefiniscono in relazione alla mutazione dei mercati in cui operano. Apple è un’azienda relativamente nuova, il cui background si basa sulla musica e sulla cultura pop. Le persone del suo team creativo, che hanno ideato la strategia di marketing per The Velvet Underground, realizzando poster, trailer e altri materiali, sono fra le più creative con cui ho avuto occasione di lavorare nella mia carriera. Abbiamo avuto discussioni su some affrontare determinate sfide, ma insieme ora stiamo cercando di superare gli ostacoli alla distribuzione del film nelle sale creati dalla pandemia. Un regista deve sempre rimanere flessibile e aperto, ma anche essere vigile su come vengano percepite le proprie esigenze, cercando di comunicarle il più chiaramente possibile.
A proposito della pandemia, come ha influito sulla produzione del film?
Nonostante tutto posso considerarmi fortunato. Avevo girato tutte le interviste già nel 2018 e coi miei collaboratori avevamo iniziato a creare un database di tutto il materiale d’archivio e dei film sperimentali sulla band. Dopodiché ho iniziato le riprese di Dark Waters – Cattive acque, uscito poi nei cinema a fine 2019. Ho rivolto nuovamente la mia attenzione verso The Velvet Underground proprio quando il Covid ha iniziato a diffondersi agli inizi del 2020. Ero a Los Angeles col mio montatore e lì siamo rimasti bloccati per mesi, avendo però tutto il materiale necessario per realizzare il film. È così che sono sopravvissuto a un periodo pazzesco, strano e spaventoso per la maggior parte delle persone. E aver fatto il lavoro in condizioni di completo e remoto isolamento mi ha permesso di scavare ancora più in profondità sui Velvet Underground.
Puoi già parlarci del tuo prossimo progetto?
È attualmente in fase di sviluppo e spero di passare alla sua produzione nei primi mesi del 2022. Si tratta di un film su Peggy Lee, nome d’arte di Norma Deloris Egstrom, cantante, attrice e autrice di canzoni statunitense, famosa tra gli anni ’40 e gli anni ’60. L’idea mi fu proposta qualche anno fa da Reese Witherspoon, che mi chiese se fossi interessato alla realizzazione di un film, dopo essere stata contattata dai detentori dei diritti dei brani della cantante, per averne parlato nelle interviste rilasciate per il film Walk the Line – Quando l’amore brucia l’anima da lei interpretato. Iniziai a sviluppare questo progetto tra le riprese di Carol e Wonderstruck – La stanza delle meraviglie, ma poi lo misi da parte per il sopraggiungere di altri impegni. L’ho ripreso durante la pandemia e sono rimasto colpito dal mondo che ritraeva: l’epoca, la cultura jazz nell’America di metà Novecento e il ruolo di una peculiare cantante dalla sessualità esplicita, quasi una Mae West della canzone popolare. Ebbe una vita complicata e dovette lottare strenuamente per diventare quella che voleva essere. Reese non è più legata al progetto, per cui la mia Peggy Lee sarà interpretata da Michelle Williams. Entrambe sono attrici straordinarie, ma conosco molto bene Michelle, che ho già diretto, e penso sia un’attrice semplicemente perfetta per questo ruolo.
Cosa rende grande un attore e un’attrice?
Vi sono innumerevoli tipologie di attori che hanno avuto un grande impatto sul cinema recitando in film che sarebbero ora inconcepibili senza di loro. Non è sempre merito di una grande formazione: molto è dovuto all’istinto o da come concepiscono la loro presenza davanti alla macchina da presa. Ho lavorato con alcuni degli attori più straordinari in circolazione e con molti di loro ripetutamente. Un esempio è Julianne Moore, che ha ben compreso la distanza tra soggetto e macchina da presa, e quanto poco sia necessario comunicare all’obiettivo. Ciò un po’ mi inquieta: la guardo recitare sul set davanti a me, ma è solo vedendo il film che comprendo quello che ha voluto comunicare. È necessaria un’incredibile fiducia in sé stessi per essere consapevoli di come il gesto più piccolo o l’emozione più nascosta riescano a comunicare in maniera più forte rispetto a una recitazione più plateale. Credo sia un dono innato, qualcosa d’intuitivo che non si possa apprendere frequentando una scuola. Julianne è incredibilmente competente e riflessiva, si considera più un’attrice tecnica che di metodo. Non le piace provare, ha un suo gusto personale su come prepararsi per un ruolo, e sa come proteggerlo. Ogni attore è differente, porta il suo approccio, le sue pratiche e la sua intuizione in un film; bisogna semplicemente fidarsi e dar loro spazio. Questa è la lezione più importante che un regista dovrebbe imparare. E Julianne continua a insegnarmi quello che solo la macchina da presa riesce a vedere.
Hai un sogno nel cassetto?
Prima di andare in pensione devo assolutamente realizzare un film su Sigmund Freud. Nonostante sia morto prima di vedere la Seconda Guerra Mondiale ed essere testimone delle atrocità naziste, ha anticipato il nostro contemporaneo, come giorno dopo giorno si scivoli verso l’autoritarismo, i sentimenti anti immigrati e i governi sempre più conservatori. Il suo pensiero è stato molto criticato e a volte ridotto a un cliché, ma in esso permane qualcosa di più radicale di quanto gli venga attribuito. Trovo che Freud sia intrinsecamente cinematografico: parla di sogni, desideri, sesso, infanzia, tutti aspetti di cui è fatto il cinema. Dopotutto il cinema e l’inconscio sono stati inventanti nello stesso periodo, per cui sono convinto che non ci sia storia migliore per essere raccontata da un film. (Intervista realizzata e raccolta il 26 e 27 settembre 2021 a Zurigo)