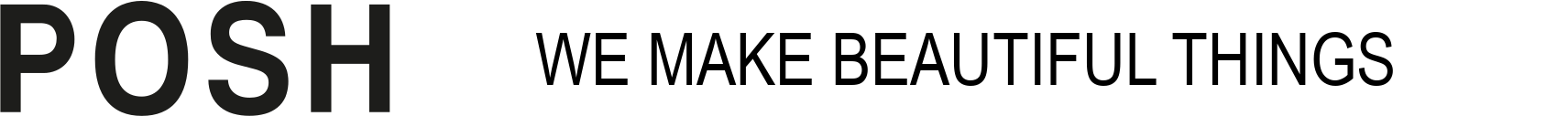L’arte e come esporla secondo Hans Ulrich Obrist
Hans Ulrich Obrist aveva diciassette anni (oggi ne ha cinquantaquattro) quando mise piede per la prima volta nello studio di un artista: si tratta del duo svizzero Peter Fischli e David Weiss. Dopo aver visto una loro mostra, l’allora studente di liceo scrive una lettera alla coppia, chiedendo di poterli andare a trovare. Da quel momento il futuro curatore visiterà gli studi di ogni artista che lo incuriosisca, uno dei primi sarà quello del tedesco, oggi novantenne, Gerhard Richter. Ed è proprio lui, Richter, a dirgli che sembrava nato per fare il curatore. Nel 1991 Obrist ha poco più di vent’anni e, dopo aver visitato un numero spropositato di mostre, si sente finalmente pronto a curarne una lui stesso. Il luogo che sceglie per allestirla è la cucina della sua casa da studente, riflettendo sul concetto di spazio quotidiano legato a un nuovo modo di concepire la curatela, una novità assoluta in quegli anni. Col tempo, Obrist sviluppa un’attrazione per quel tipo particolare d’arte che non è “permanente” e che non si appende ai muri. Predilige opere che riflettono tematiche di attualità, che provocano la riflessione e la critica attraverso la performance, che spesso include la partecipazione attiva del pubblico. Le mostre curate da Obrist sono semi che possono crescere, maturare: senza tempo, spazio, e limiti intellettuali. Oltre ad essere uno dei curatori più importati del mondo Obrist è interessato alla scrittura. Fin dal 2014 ha messo insieme duemilaquattrocento ore di interviste ad artisti, e continuano ad aumentare. La domanda che più gli piace rivolgere ai suoi interlocutori è: “Hai qualche progetto non finito, o mai realizzato?”. Citando l’autore inglese James Graham Ballard, descrive il proprio lavoro curatoriale come “junction-making”, una sorta di ponte tra discipline, ciò che sta “in between” (in mezzo), qualcosa di radicalmente opposto all’idea che tutto sia unico e non possa essere contaminato. Obrist ha rituali che scandiscono il suo stile di vita articolato, fatto di molte ore di lavoro e poche ore di sonno, di numerosi viaggi alla scoperta di artisti emergenti, di lunghe conversazioni con artisti e colleghi, spesso notturne o estremamente mattiniere – ha fondato il Brutally Early Club, per persone che si incontrano alle 6.30 di mattina in diversi luoghi di Londra. La sua parola preferita è “urgente”, ha confidato a The New Yorker, che sembra proprio descrivere la frenesia dei suoi movimenti e la velocità dei suoi pensieri. Il tempo di Obrist, sin dall’adolescenza, sembra essere diverso dal tempo di tutti.
Lo abbiamo intervistato in un pomeriggio di luglio, al telefono, mentre si trovava in un’isola greca.
D: In un mondo che apprezza sempre di più uno stile di vita lento, che dedica più tempo ai propri bisogni e piaceri, in particolar modo dopo essere stato colpito dalla pandemia, come concilia il suo modo di vivere frenetico ed estremamente produttivo, con il tempo delle altre persone?
R: Ho sempre dato molta importanza al tempo, anche al tempo liberato, che è vitale per ciascuno di noi. La pandemia mi ha portato a lavorare in modo diverso, ma il vero cambiamento in me è avvenuto negli ultimi dieci anni, con l’interesse che ho sviluppato per gli scritti del filosofo Roman Krznaric, specialmente dopo aver letto il suo libro How to be a good ancestor. Nel libro Krznaric spiega come il mondo in cui viviamo sia spesso guidato da una visione delle cose a breve mentre, secondo lui, bisognerebbe invece preferire progetti a lungo termine. Il progetto Do It, che ho inaugurato addirittura nel 1993, è un ottimo esempio di questa filosofia: evolve lentamente, cambia con noi e porta con sé nuovi insegnamenti. Sono istruzioni e “ricette” di manuali di artisti che le persone possono leggere e interpretare a modo loro. È un progetto che si può svolgere ovunque, con artisti e materie prime locali. È sostenibile poiché si adatta al cambiamento e, soprattutto, non ha una scadenza. Il fenomeno in crescita di mostre ed eventi si è sviluppato solo ultimamente. Guardando indietro nel tempo della storia dell’arte, e ricordando per esempio Alberto Giacometti – che ho studiato in Svizzera quando ero ragazzo – mi viene in mente che lui poteva passare anche dieci anni a lavorare in studio prima di presentare un’opera. È importantissimo per me seguire costantemente gli artisti e ascoltarli, capirne i progetti futuri e vedere come evolvono nel tempo. Molti artisti contemporanei stanno scegliendo format diversi per i loro progetti, spesso a lungo termine. L’artista visiva Otobong Nkanga vuole costruire una società agricola in Nigeria, che è l’emblema di un piano a crescita lenta, che si basa sull’importanza dell’ambiente e dell’ecologia. Credo che l’arte abbia un ruolo attivo nello sviluppo della società. L’artista Alexandra Daisy Ginsberg per esempio, ha contribuito al progetto Back to Earth creando un giardino piuttosto inusuale nei pressi della Serpentine Galleries a Londra. Si intitola “Pollinator Pathmaker” e usa un algoritmo particolare. L’idea è quella di liberarsi da una visione a breve termine, pensando al futuro. Viene in mente il grande Gianfranco Baruchello, che ha lavorato in questo modo sin dagli anni ‘60.
D: Cosa significa per lei anticipare il tempo?
R: La parola chiave è ricerca. Si tratta di ricercare la novità così come è importante studiare il passato. Per me, in particolare, significa anche visitare gli studi degli artisti. Non credo che i curatori siano necessariamente capaci di anticipare il tempo. Gli artisti, molto più probabilmente lo sono. A noi non resta che scoprirli, studiarli, conoscerli, rimanendo con gli occhi sul presente e la mente rivolta al futuro.
D: L’idea di un progetto non finito o non realizzato la affascina molto. Quando, secondo lei, un’opera può dirsi terminata?
R: È una domanda che pongo spesso agli artisti e solitamente è molto difficile ricevere una risposta. Credo sia una questione di intuito. Forse, la risposta più frequente è che un lavoro può dirsi terminato quando non c’è più niente da aggiungere. Alcune opere non sono mai concluse. Basti pensare alla “Sagrada Familia” di Antoni Gaudì a Barcellona. È ancora in costruzione. Non credo che questa domanda abbia una risposta univoca.
D: Si è avvicinato al mondo dell’arte molto giovane, visitando gli studi di diversi artisti quando era appena adolescente. Cosa osserva di solito nei loro studi?
R: Osservo la cultura che li circonda, gli esperimenti e soprattutto i disegni. La più recente è stata la visita allo studio dell’artista Liliane Lijn, che ha lavorato con la scienza e l’arte da molto tempo ormai. Lì ho avuto modo di conoscere anche i suoi progetti non terminati o mai realizzati. Sono attratto dai disegni in particolare perché credo che siano rappresentativi del nucleo creativo di un artista. Anche gli artisti concettuali spesso cominciano dal disegno. La visita allo studio permette di entrare nella loro realtà intima, quella delle idee.
D: Il concetto di “togetherness” (lo stare insieme), è uno dei capisaldi della sua idea di curatela. In che modo l’arte unisce le persone?
R: Credo che il mondo abbia bisogno di unità e non di separazione, di un futuro comune e non di isolamento, di amore e non di sospetto, come scrisse la poetessa e artista Etel Adnan. Aggiungerei che abbiamo anche bisogno di nuovi rituali in quest’era della comunicazione e della crescita esponenziale dell’informazione. Gli artisti sono molto bravi nella creazione di nuovi rituali. Potrei elencare innumerevoli motivi per cui abbiamo bisogno dell’arte. Un’altra cosa che unisce è sicuramente la memoria. Progettare il futuro è tanto importante quanto tenere conto del passato, ricordare è essenziale.
L’intervista completa su Posh 104